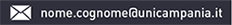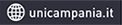Assetti organizzativi adeguati dopo il correttivo-ter al Codice della crisi - di Emanuela FUSCO
in Giustizia Civile, 2024, fasc. 3, p. 647 - 704
Il saggio analizza il tema degli adeguati assetti organizzativi societari in funzione della tempestiva rilevazione della crisi d’impresa, anche alla luce delle novità introdotte dal correttivo-ter (d.lgs. n. 136/2024) al Codice della crisi. Obiettivo dell’indagine è individuare le condotte doverose imposte agli organi amministrativo e di controllo delle società. Secondo la tripartizione operata dal Codice, viene dapprima analizzato l’obbligo di istituzione degli assetti organizzativi “adeguati”, che – secondo un principio di proporzionalità – è declinato in base al criterio qualitativo e quantitativo della natura e delle dimensioni dell’impresa. Segue una breve disamina dell’obbligo di vigilanza sugli assetti adeguati e dell’obbligo di segnalazione dell’organo di controllo. Infine, si ricostruisce il contenuto del dovere di adozione delle misure di reazione da parte degli organi gestorio e di controllo, nelle varie fasi che l’impresa si trovi ad attraversare, dalla precrisi (c.d. twilight zone) alla perdita della continuità aziendale (crisi) fino all’insolvenza, seguendo la gradazione ascendente scandita dal Codice.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
Profili di crisi degli Early Warnings Tools. Spunti di riflessione dall’intelligenza artificiale - di Luca SICIGNANO
in Il dir. fall. e delle soc. comm., 2024, fasc. 4, p. 886 - 921
Il lavoro analizza l’implementazione degli Early Warnings Tools previsti dalla direttiva (UE) 2019/1023 nel Codice della crisi e più in dettaglio l’istituto dei meccanismi di allerta (o anche «alert mechanisms») previsti legislatore nazionale. Il fine del lavoro è quello di valutare l’efficacia e l’efficienza di questi meccanismi per valutare la possibilità di impiegare e implementare strumenti predittivi o algoritmi di intelligenza artificiale, interni o esterni all’impresa, per la previsione anticipata degli stati di crisi o pre-crisi.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
La crisi della composizione negoziata - di Maria Consiglia DI MARTINO
in Nuov. Legg. civ. comm., 2024, fasc. 3, p. 708 - 742
Il contributo esamina l’istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto dal d.l.24 agosto 2021, n. 118, e successivamente confluito negli artt. 12-25-quinquies del codice della crisi d’impresa. Particolare attenzione è dedicata alle caratteristiche della spontaneità dell’accesso a questa misura e alla sua natura stragiudiziale, mettendo in evidenza come i bias cognitivi degli imprenditori o degli amministratori possano costituire un ostacolo alla sua diffusione.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
La nuova finanza negli strumenti preconcorsuali di risanamento: la prededuzione prevista nell’ambito della composizione negoziata della crisi - di Massimo RUBINO DE RITIS
in Giust. civ., 2024, fasc. 1, p. 71 - 94
Il saggio analizza in dettaglio l'evoluzione della disciplina relativa ai finanziamenti concessi alle imprese in crisi attraverso strumenti preconcorsuali di risanamento, con una particolare attenzione alla prededuzione nel quadro della composizione negoziata della crisi, esplorando il contesto storico che ha portato a una serie di riforme legislative, incrementando progressivamente l'accessibilità al credito per le imprese in difficoltà e rafforzando le garanzie per i finanziatori tramite la prededuzione. Vengono esaminati gli effetti delle norme sulla continuità aziendale, la migliore soddisfazione dei creditori e la gestione del rischio da parte dei finanziatori. Si affronta in dettaglio il ruolo del tribunale nel valutare la funzionalità dei finanziamenti rispetto agli obiettivi di continuità aziendale e i problemi che in concreto si pongono, indicando le possibili soluzioni.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
La ristrutturazione automatizzata del debito - di Mario PASSARETTA
in Giust. civ., 2024, fasc. 1, p. 95 - 116
Il saggio esamina l’introduzione, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, del sistema di ristrutturazione automatizzata del debito, ex art. 25-undecies CCII, evidenziando come questa innovazione rappresenti un tentativo di risposta immediata alla crisi. Il contributo, in particolare, affronta vari aspetti del sistema negoziale (automatizzato), inclusi i requisiti per l’accesso, la comunicazione e l’adesione dei creditori, nonché le implicazioni del dissenso anche di uno solo di questi, oltre alle conseguenze dell’inadempimento del debitore, individuando, così, in assenza di una espressa previsione normativa, una serie di regole applicabili.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
L'assenza di pregiudizio e il rischio di insuccesso dei piani concordatari - di Luca SICIGNANO
in Banca, Borsa e tit. cred., 2024, fasc. 1, p. 144 - 176
Il contributo esamina il principio di assenza di pregiudizio vigente nelle procedure concorsuali, secondo cui occorre verificare che ai creditori non aderenti ad una procedura di liquidazione o di ristrutturazione venga assicurata una soddisfazione almeno pari all’importo astrattamente ricavabile da un’ipotetica liquidazione giudiziale. Nello specifico, l’analisi si sofferma sul funzionamento concreto del principio e sull’effettiva modalità di determinazione delle cifre poste alla base della verifica, ossia del valore di liquidazione e di pagamento. In questa prospettiva, la tesi sostenuta dall’Autore è che nella determinazione del valore di pagamento per la verifica dell’assenza di pregiudizio bisognerebbe applicare i criteri economici dell’attualizzazione e, così, introdurre nel confronto anche il valore economico del rischio associato alle concrete modalità di soddisfazione promesse ai creditori.
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)
La convenzione di moratoria e il contratto a sfavore di terzo - di Mario CAMPOBASSO
in Riv. dir. civ., 2023, fasc. 6, p. 1051-1079
Fra le numerose novità legislative proposte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza vi è la convenzione di moratoria, con la quale il debitore può convenire con i creditori «la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito» (art. 62 c.c.i.i.). Se all’accordo aderiscono i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti di una categoria, la convenzione è efficace per tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria. La convenzione di moratoria è perciò un “contratto a sfavore di terzo”, vale a dire a sfavore di quei creditori che, senza aver aderito alla convenzione, sono vincolati dagli effetti dell’accordo accettato dalla maggioranza dei creditori della categoria. Ciò in deroga espressa al c.d. principio di relatività del contratto, secondo cui il contratto produce effetti diretti solo tra le parti (art. 1372 c.c.). La tensione del nuovo istituto con i principi fondamentali del diritto privato è evidente; i dubbi numerosi. Quando un contratto può essere definito “a sfavore di terzo”? A quali condizioni il legislatore può consentire ai privati l’impiego di un simile strumento senza violare le libertà costituzionali del terzo? Quando è utile farvi ricorso e quando, invece, controproducente ? Quali sono le tutele apprestate per il terzo in sede di stipula del contratto e poi di fronte alle vicende sopravvenute del rapporto?
Estratto PDF (limitato alle prime 5 pagine)